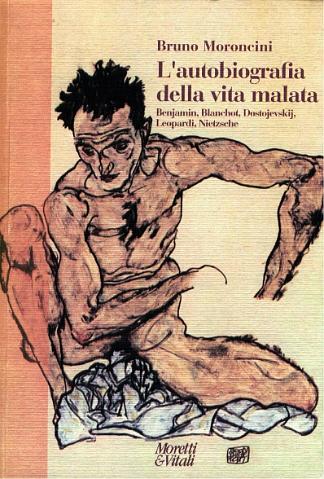Uno
dei tratti decisivi della cultura otto-novecentesca è
rappresentato dal rapporto che sempre più profondamente viene
a istituirsi fra la scrittura autobiografica e l’esperienza
della malattia, sia fisica, sia psicologica o spirituale. A partire
da Nietzsche, infatti, la malattia e la degenerazione vengono assunte
non come segni di decadimento, ma al contrario come manifestazioni
indirette di “potenza”, momenti in cui la vita raggiunge
il grado più alto di intensità. La malattia, il
disadattamento, l’impossibilità di corrispondere agli
standards comportamentali imposti dalla società, diventano
così la condizione dell’invenzione letteraria,
artistica, filosofica e, perché no, politica.Tale esito
sarebbe tuttavia impossibile se non fosse accompagnato dal racconto
della vita: solo l’esperienza della scrittura — poetica,
letteraria e filosofica —, intesa alla maniera di Blanchot come
un’esperienza della perdita e della fuoriuscita da se stessi,
fa in modo che ciò che rischiava di restare relegato nella
sfera degli accidenti empirici si trasformi in significante
soggettivo, prima, e condizione dell’invenzione delle forme e
dei concetti, dopo.
Il
libro ripercorre attraverso cinque nomi, cifre di altrettante
esperienze fondamentali del pensiero e dell’arte fra Otto e
Novecento, questo nodo che lega la scrittura autobiografica e
l’esperienza della vita malata: parte da Leopardi tentando di
smontare l’interpretazione crociana del poeta fondata sul
concetto di “vita strozzata”; prosegue con l’Ecce
homo di Nietzsche e con tutta la questione della sua follia;
passa per l’epilessia di Dostojevskij intesa come chiave per
capire la figura dell’Idiota; si sofferma sulla
spiritualità anerotica e sul carattere celibitario di Walter
Benjamin; e si chiude sulla follia blanchotiana di voler vedere
l’invisibile, di abitare il centro accecato della luce.
|