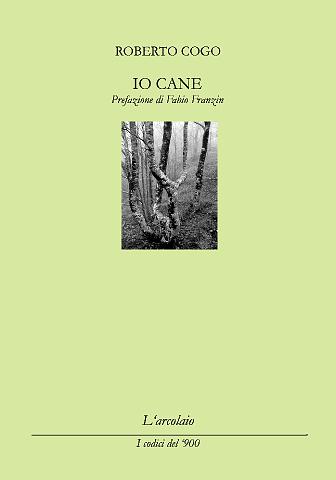|
“Io
cane” di
Roberto Cogo
Nota critica di Armando Bertollo
L’io
del poeta si fa ‘animale’, annusa l’ambiente, lo
percorre, lo esplora sfiorandolo con i sensi. Si fa amico fedele. Si
è lasciato educare. Questa scrittura, infatti, viene da un
processo di educazione dell’esperire e vivere la realtà
inaugurato dal libro precedente, “Di acque/Di terre”. Con
una scrittura controllata, spesso oggettiva e comunicativa,
colloquiale a tratti, talvolta sulla soglia aurorale del senso,
l’autore ha scelto con convinzione di affidarsi alla natura, di
esserne fedele, di ascoltarla, di viverla empaticamente, scrivendo il
piacere di coglierne il respiro, l’odore, riscattarne il valore
di fondamento, rispettarne il mistero. Il poeta ricerca la
‘naturalezza’ anche nel linguaggio, che tende al discorso
che si chiarisce, come acqua sorgiva, con echi di classicità
cosmopolita, di “una bellezza senza sfoggio”.
Roberto Cogo osserva alberi, nuvole, acque, e altri fenomeni ed
esseri con rinnovata verginità. O forse con la nostalgia dello
sguardo vergine degli uomini di altri tempi: uno sguardo, in realtà
non più recuperabile nella sua originaria purezza. Eppure in
questo libro accade che il poeta di oggi possa descrivere la sua
salvezza, la sua ‘persuasione’, un personale sollievo dal
‘pessimismo cosmico’ di leopardiana memoria, proprio
nell’esperienza di ‘vivere’ e ‘sentire’
concretamente la realtà ambientale, e farne motivo di
scrittura. Una comunione a—teologica, eppure profondamente
carica di sacralità, rispetto, devozione, positività:
“l’incommensurabile
natura delle cose da indagare
senza
le angeliche presenze o divine
che non siano dentro
il miracolo della presenza in quanto
tale
l’emanazione sacra e la scintilla di vita
in
ogni cosa --
né buona né cattiva né
bella né brutta
ma carica del proprio elemento vitale
--l’adesione
svuota la mente da ogni pretesa”
...Se poi il
titolo di questo libro suona come una bestemmia, l’imprecazione
è rivolta all’io iperbolico, ipertrofico, dell’uomo
occidentale e occidentalizzato, che si è volutamente snaturato
per affidarsi ciecamente alle promesse della tecnica, direbbe
Severino. Un uomo che usa e consuma l’ambiente dimentico di
esserne parte e parte dipendente. Colpevole di rincorrere l’hybris
di controllo, di possesso, di consumo, appunto. L’autore
condensa nel titolo la sua ombra, ciò che non può dire,
la rabbia, l’indignazione. Pertanto “Io cane” è
volutamente ambiguo, aperto all’essere animale che si avventura
richiamato dai sentieri matrici e materni — non più
matrigni, come per l’autore dell’Infinito — dove
l’io può diventare ancora “merlo”,
“insetto”, “albero”, “acqua”,
“uccello”, “legno”, “pesce”, e
accusa al perenne cantiere della modernità che divora la
natura, la bestemmia — si potrebbe dire, capovolgendo la
prospettiva — per fare business. In quell’ombra di non
dicibile si potrebbe celare l’intenzione del finale di
“Zabriskie Point”: un’apocalisse purificatrice. Ma
in realtà resta chiara solo un’imprecazione. Il poeta
attende la parola e fa “ciò che deve”:
vigila per la salvezza di ciò che ama:
“piante
di vario tipo e colore
sono toppe screziate di un abito antico
dove restare per sempre avvolti tutti insieme”
(9 agosto 2009)
|